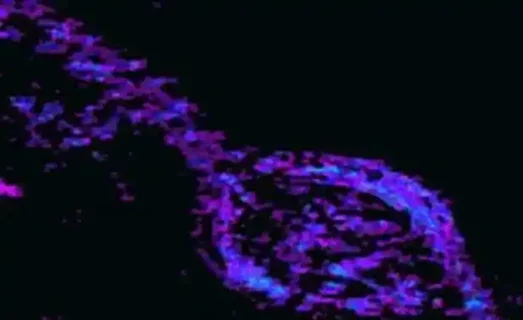INTERATTIVITÀ DIGITALE. Nuove musiche, nuove creatività. Applicazioni nei percorsi didattici e nel dialogo fra gruppi sociali emergenti. Gli Iperstrumenti (altrimenti definiti Strumenti Digitalmente Aumentati) sono sistemi interattivi che estendono le potenzialità creative degli interpreti su strumenti musicali acustici (ma anche di danzatori, attori, artisti grafici) tramite sensori che tracciano i movimenti funzionali alla produzione sonora, e li integrano con analisi audio in tempo reale secondo metodologie programmate per estrarre e focalizzare specifiche caratteristiche sonore e musicali emergenti all’interno di una pubblica performance. Tali sistemi di tecnologia applicata forniscono in primis un potente mezzo di investigazione delle componenti corporee, emozionali e stilistiche del performer, e possono divenire perciò un potente mezzo di analisi orientabile a finalità psicoacustiche, comunicative, musicologiche, psicologiche, antropologiche. La potenzialità creativa ed espressiva di queste tecnologie consiste nel far convergere i dati di analisi del gesto performativo in un circuito sonoro elettroacustico programmato per rispondere e per trasdurre i gesti del performer in entità musicalmente organizzate. La computer music permette di creare composizioni elettroacustiche e composizioni algoritmiche in grado di variare sé stesse e determinare propri autonomi sviluppi con alti gradi di flessibilità e in risposta a stimoli e dati variabili di input. In altre parole, le stesse componenti e gli stessi dati di analisi digitale psicoacustica, emotiva, stilistica e gestuale che indagano in tempo reale i comportamenti del performer sul palco, vengono reintrodotti all’interno delle sonorità e delle strutture musicali elettroacustiche come variabili in tempo reale, che produrranno quindi una musica sensibile ai contesti e agli eventi che si svolgono sul palco. In tal modo, si fornisce al performer una chiara percezione della propria acquisita facoltà di generare tecnologicamente una musica che corrisponde alle proprie decisioni, anche a quelle estemporanee. Se gli stessi dati di analisi della performance vengono opportunamente visualizzati dal performer (ad esempio sullo schermo di un laptop, sul palco, in modalità numerica o grafica, o trasformati secondo concordate simbologie), i dati di autoanalisi potranno venire utilizzati come partitura grafica e in animazione, in modo da fornire al performer stesso un ulteriore mezzo di interazione musicale algoritmica, secondo procedure simboliche. Si considerano qui Iannis Xenakis, Tod Machover e George Lewis come grandi pionieri; tra i numerosi sviluppi di tecnologie interattive emersi negli ultimi 3 /4 decenni, il relatore illustrerà alcuni propri progetti in eventi concertistici per solisti ed ensemble, spesso in collaborazione con
compagnie di danza, attori e gruppi di ricerca scientifica. Verrà dato un particolare accento alle applicazioni didattiche e a progetti di carattere transculturale orientati a valorizzare gli aspetti estemporanei e intra-soggettivi nella comunicazione musicale fra musicisti di diverse formazioni culturali ed etniche – in particolare i progetti Saundaryalahari e Fughe e Confluenze.
MA/IN, 2016
The Trees, 2016
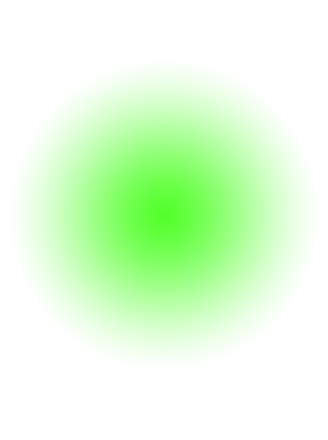
Augmented Cellos, 2018
Contributi scientifici
2014
Conferenza EMS, Berlino
2019
Generative Art Conference, Roma
Contributo alla pubblicazione
L’improvvisazione non si improvvisa, a cura di Fabio De Sanctis De Benedictis © 2020 Istituto Superiore di Studi Musicali “Pietro Mascagni” di Livorno
The Speckled Cellist
D. Mukherjee, D. K. Arvind
Progetti
Violoncello Totale
Cello e Iper-cello
Messaggi da Kafka
Workshop a Genova, 2015
Intervista, 2018
Kobane, 2019


Associazione Mask APS
Festival internazionale di nuova musica
PROGRAMMA
XII. MaskFest 2022
Metamorphosis meets Haiku
in collaborazione con la Merkin Hall di New York
8 Aprile
Merkin Hall, Kaufman Music Center, NY
Saundaryalahari
1 Dicembre
Centro di Ricerca Musicale, Teatro San Leonardo, Bologna


Hot Strings II, 2018
Awakening, 2015
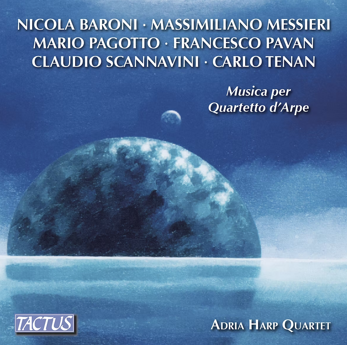

METAMORPHOSIS MEET HAIKU
Patrizia Romanello, piano
8 Aprile 2022, ore 19:30
Merkin Hall, Kaufman Music Center
Abraham Goodman House, 129 West 67th Street, New York
In collaborazione con la MERKIN HALL di New York
The concert pianist Patrizia Romanello compares the poetics of two composers of different generations, Philip Glass (1937) and Massimiliano Messieri (1964). The concert opens with one of the masterpieces in Glass's piano catalog, namely "Metamorphosis". The program continues in the Mediterranean area with some compositions by Massimiliano Messieri "Fantasia", "Fantasia No.2 - Traveling with Patrizia", "Haiku", a selection from "12 Haiku" that he dedicated to Patrizia Romanello herself. This concert is an inner journey of the mind among the memories of the unconscious, a return to the archaic with the musical knowledge of classical and contemporary history.
ARTISTS/INSTRUMENTS
Patrizia Romanello / Piano
COMPOSERS/TITLES
Philip Glass / Metamorphosis (1988)
Massimiliano Messieri / Fantasia (2019)*
Massimiliano Messieri / Fantasia No.2 - "Traveling with Patrizia" (2020)*
Massimiliano Messieri / Haiku (2020)*
* American Premiere
Patrizia Romanello dopo aver conseguito gli studi musicali al Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro, si perfeziona sotto la guida del Maestro Giovanni Valentini, che amplia in modo considerevole i suoi orizzonti musicali. Per quanto concerne la Musica da Camera, si perfeziona con M. Damerini, V. Brodski e in seguito grazie agli insegnamenti di Pier Narciso Masi si diploma brillantemente nel 2005 col titolo onorifico di “Master”, la qualifica più alta rilasciata dall’Accademia Internazionale “Incontri col Maestro” di Imola. Contemporaneamente agli studi di perfezionamento, nel 2003 vince il primo concorso per pianisti collaboratori al Conservatorio G. Rossini di Pesaro e successivamente anche il medesimo concorso al Conservatorio G. Frescobaldi di Ferrara. In breve tempo la Romanello accumula un repertorio vasto di Musica da Camera che le permette di collaborare con Maestri di fama mondiale nell’ambito di corsi di perfezionamento, masterclass e concerti, tra cui A. Paulsson, A. Vasiliev, P. Geiss, N. Zimin, F. Mondelci, O. Murphy, J. Laran, R. Donati, A. Bocini, A. Sciancalepore, P. Scarpa, M. Albonetti, S. Milenckovic, A. Hall, F. Dego, A. Quintanilla, N. Bulfone, G. Arbonelli, C. Palermo, F. Meloni, G. Picciati, C. Giuffredi, E.M. Baroni, P. Beltramini, M. Benzi, M. Mariotti e M. Marvulli, per citarne solo alcuni. Si esibisce in molte città italiane tra cui Bologna, Chieti, Ferrara, Fermo, Firenze, Imola, Milano, Modena, Monza, Napoli, Parma, Pescara, Roma, Teramo, Terni, Senigallia, ecc.; incidendo CD per la Sarx Records, per la Fondazione “Ino Savini” e registrando per la RAI. Eclettismo e versatilità unite ad una considerevole sensibilità, le permettono di spaziare fra una vasta gamma di repertori, dalla musica barocca alla contemporanea, eseguendo partiture di compositori come Graham Fitkin, Daniela Silvestrini, Michele Mariotti, Helmut Laberer “Klangbilder” concerto per pianoforte, percussioni e orchestra (Orchestra Sinfonica di Pesaro) e di Roberto Molinelli “Four pictures from New York“, dove la Romanello è solista nel trio jazz “Sentimental evening” accompagnata dall’Orchestra Sinfonica di Pesaro. Dal 2019 è la pianista principale di Massimiliano Messieri che le ha dedicato anche numerose partiture. Nel 2020 tiene la Masterclass “Analisi funzionale per interpreti” presso l’Istituto Superiore Studi Musicali “Pietro Mascagni” di Livorno. Dal 2021 considerevoli progetti vedono la Romanello in veste di solista e in duo in prestigiose stagioni concertistiche, tenendo recital in importanti sale come la Merkin Hall del Kaufman Music Center di New York, l’Istituto Liszt di Bologna, la Sala Mozart di Rovereto e in città musicali come Vienna e Chicago.


SAUNDARYALAHARI
giovedì 1 dicembre 2022, ore 19:30
Centro di Ricerca Musicale / Teatro San Leonardo, Bologna
John Cage (Stati Uniti, 1912-1992)
Aria (1954) per voce femminile
Massimiliano Messieri (Italia, 1964)
Okure ite (2018) meditazione per soprano, tromba, violoncello, percussioni e elettronica
prima italiana
Nicola Baroni (Italia, 1959)
Hamsa (2018) per tromba preparata, violoncello, gong e sistema interattivo di analisi del suono e generazione spettrale
prima italiana
Georges Aperghis (Grecia, 1945)
Recitation No. 8 e No.9 (1977) per voce femminile
Yati Durant (Stati Uniti, 1974)
Saundaryalahari 7 (2022) per voce, tromba, violoncello, percussioni, elettronica e immagini
prima assoluta
Elena Tereshchenko soprano, percussioni; Nicola Baroni violoncello, elettronica; Yati Durant tromba, elettronica; Massimiliano Messieri elettronica, percussioni
musiche di John Cage, Georges Aperghis, Yati Durant, Nicola Baroni, Massimiliano Messieri
Mask in collaborazione con AngelicA | Centro di Ricerca Musicale
l Soundarya Lahari o Saundarylahari, che dal sanscrito (सौnय%लहरी) significa “Onde di bellezza”, è una famosa opera letteraria che si ritiene sia stata scritta in India dal saggio Pushpadanta e Adi Shankara nell’VIII secolo, nell’attuale Kerala.
John Cage
John Cage (Stati Uniti, 1912-1992)
Aria (1959); per voce femminile
Composizione dedicata a Cathy Berberian, la partitura di questo lavoro virtuosistico è composta da 20 pagine di musica annotata graficamente, ciascuna pari a 30 secondi di esecuzione. Detto questo, le pagine possono essere eseguite su intervalli di tempo più o meno lunghi per creare un programma di una determinata durata. Aria può essere eseguita in solo, o con nastro magnetico e/o con una qualsiasi delle parti che compongono il Concerto per pianoforte e orchestra. Il testo è composto da vocali e consonanti isolate, nonché da parole dall’armeno, dal russo, dall’italiano, dal francese e dall’inglese. La notazione è colorata e grafica, costituita, essenzialmente, da linee ondulate di diversi colori e 16 quadrati neri che denotano rumori vocali “non musicali”. I colori denotano diversi stili di canto, che sono determinati dal cantante prima dell’esibizione. Cage ha utilizzato il nastro magnetico come mezzo di composizione per creare Aria.
Massimiliano Messieri
Massimiliano Messieri (Italia, 1964)
Okure ite (2018); meditazione per soprano, tromba, violoncello, percussioni e elettronica
prima italiana
Ispirati a un tanka (il primo) e a un haiku (il secondo) del monaco Saigyo, sono due meditazioni sulla realtà delle cose e sul varcare la soglia dell’ultima porta. Come scrive Saigyo: Okure ite / namida ni shizumu / furusato o / tama no kage ni mo / aware to ya mimu (Anche le anime / vanno nell’aldilà / guardano con compassione / quelle che in lacrime / sono rimaste al mondo), noi riusciamo a capire l’essenza della realtà solo nella sua assenza, guardiamo il passaggio da una direzione senza fermarci a pensare che questa dimensione in cui viviamo potrebbe non essere quella migliore e per contrapposizione ci accorgiamo dell’importanza di una persona solo quando essa non c’è più. Questo concetto applicato alla musica ci obbliga ad osservare diversamente l’atto creativo, cosa significa superare il suono e creare musica? Il suono è una vibrazione (onda) che il timpano percepisce, mentre una serie di suoni organizzati (E. Varèse) dovrebbero essere musica, quindi il silenzio (non suono) dovrebbe essere l’incrocio del suono? O il suono previsto (non percepito) è la risposta corretta? Quindi per comporre musica, è necessario aggiungere suono al silenzio o toglierlo?
Nicola Baroni
Nicola Baroni (Italia, 1959)
Hamsa (2018); per tromba preparata, violoncello, gong e sistema interattivo di analisi del suono e generatore di spettro
prima italiana
Hamsa è un uccello migratore che simboleggia la nostra mente limitata e l’anima migrante. La letteratura delle Upanishad ci dice che Hamsa è il suono fisico del ciclo del respiro (“Ham-Sa” inspirazione-espirazione), e di conseguenza una tecnica per unire il suo ritmo, per riconoscere le sue emozioni collegate e per fornire un processo di liberazione attraverso la meditazione.
Se l’Universo, seguendo Pitagora, è una corda vibrante estremamente lenta, Harmony, seguendo Lao Tsu, è la sintesi di Equilibrio e Movimento. Le tecniche musicali mirano a generare armonie come sviluppo combinatorio e vincolo delle espansioni naturali del suono, che è vibrazione e respiro. Ma l’associazione Natura e Cultura non è mai lineare, mescolando libertà con schiavitù e migrazioni. Il dialogo tra gli artisti attraverso il sistema elettronico complesso è una ricerca, una produzione e una creazione di ambienti armonici artificiali messi in atto collettivamente dal timbro, dal respiro e dal ritmo dei suoni acustici.
Georges Aperghis
Georges Aperghis (Grecia, 1945)
Recitation No. 8 e No. 9 (1977); per voce femminile
Parti di una composizione per teatro della durata di 45 minuti (2 agosto 1982, Festival d’Avignon, con Martine Viard e Michel Rostain, regista), le Recitations sono, come dice Daniele Durney, “una recitazione imparata a memoria, come quella dello scolaro che a volte esita, ma poi raggiunge, rendendo ancora più poetico il percorso del senso che la ripetizione meccanica consente”.
È un ritratto di donne. Possiamo enumerare, elencare, inventariare (parole care al compositore) gli atteggiamenti che il compositore suggerisce all’esecutore in ogni momento: determinato (Recitazione 10, parte sinistra, 1a versione), coccoloso ma forse indifferente (5), contemplativo sul sull’orlo della crudeltà (13), giovanissima ragazza che si apre alla vita, ascoltando sua madre (8, parte centrale, versione verticale), mondana ma moltiplicata (11), accettando il suo destino, e quasi disincarnata (14). Perché ogni Recitazione è un minuscolo teatro a sé stante. Giochiamo sulla lingua, sul suo fruscio. È l’umanità, più in generale, di cui parla il compositore. Ci si trova nella situazione di chi deve inventare il piccolo alfabeto del mondo.
Yati Durant
Yati Durant (Stati Uniti, 1974)
Saundaryalahari 3 (2022); per voce, tromba, violoncello, percussioni, elettronica e immagini
prima assoluta
Il lavoro presenta un sistema di sviluppo di immagini interattive utilizzando il software Pixivisor, che traduce l’immagine in suono e viceversa, fornisce l’opportunità all’esecutore di avere un Loop “feed forward” per rigenerare materiali musicali all’interno di una composizione. Tra questi suoni processati ci sono il violoncello solo e i suoni manipolati elettronicamente creati da un sintetizzatore modulare, suoni sequenziati e campionati creati da Machinedrum e materiale tratto dalla partitura. Il Soundarya Lahari o Saundarylahari (sanscrito: सौnय%लहरी) che significa “onde di bellezza” è una famosa opera letteraria in sanscrito che si crede sia stata scritta dal saggio Pushpadanta e Adi Shankara. È stato scritto nell’VIII secolo dell’attuale Kerala, in India. Il lavoro si basa sulla formazione spirituale / grafica dello Sricakra (sopra) che definisce la disposizione dei versi dall’esterno all’interno. Ogni verso contiene una poesia in sanscrito che stabilisce un riferimento spirituale / filosofico alla struttura dello Sricakra. Le poesie sono costruite come un inno a Devi inserite all’interno del monismo Advaita Vedanta di Adi Shankara e si riferiscono al sociale universale e ai fattori spirituali che influenzano molte cose, inclusa la creatività delle fonti. Poiché il sistema Pixivisor può anche essere interattivo da remoto (anche per il pubblico), potrebbe esserci la possibilità per il pubblico di visualizzare le uscite audio in formato visivo sui propri dispositivi smartphone all’interno del concerto.